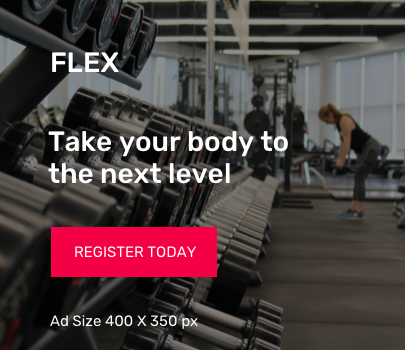Domenica scorsa, nelle nostra pagina dedicata ai libri, avevamo analizzato alcuni aspetti de La città dei vivi di Nicola Lagioia. Si era visto come l’atroce delitto di Luca Varani avesse gettato nello sconforto i romani, che tra lo sgomento e la rabbia iniziarono a chiedere giustizia fin dalle prime battute dell’indagine: “Il cinismo era l’aria che respiravano tutti”.
Questa voglia di giustizia, quasi di vendetta, il dolore condiviso, la ricerca della verità, sono tutti elementi che da sempre costituiscono un humus fertile sul quale una comunità costruisce il suo senso di appartenenza. Le persone pretendono che le istituzioni le riconoscano, per questo a volte sono pronte a manifestare, scioperare, arrivare anche allo scontro, affinché venga rispettato quel velo di umanità strappato da un gesto violento oppure offeso da una decisione considerata popolarmente ingiusta.
Proprio nelle ultime settimane, si è aperto il processo a carico di un giovane di Collegno, che un anno fa, uccise il padre per salvare la madre dai suoi continui maltrattamenti. Un caso destinato a far discutere per quel sottile confine tra giustizia e vendetta, tra attenuanti e volontarietà.
Questa vicenda ricorda da vicino la storia romana, divenuta ormai un mito, di Beatrice Cenci, una ragazza di soli 16 anni condannata a morte per aver ucciso il padre dopo una lunga serie di sevizie e abusi.
Nella memoria storica della città, Beatrice Cenci, rappresenta un’eroina atemporale. La sua vicenda è stata conservata e tramandata fino ai giorni nostri da un’innumerevole serie di studi, pubblicazioni, dipinti, sculture, opere teatrali e cinematografiche (ad oggi si contano ben nove pellicole!), fino a comparire come fantasma in un numero di Dylan Dog.

Oggi vi presentiamo il libro Beatrice Cenci romana storia del secolo XVI (Intra Moenia edizioni). La ristampa di un testo anonimo comparso nel 1849. Le pagine propongono una breve introduzione sulla storia della famiglia Cenci e la ricostruzione delle indagini, del processo e della condanna a morte della giovane ragazza, decapitata in pubblica piazza l’11 settembre 1599.

Francesco Cenci, padre di Beatrice, era un potente nobile romano, tra i più ricchi della città. Aveva però uno stile di vita dissoluto, uomo violento e responsabile di diversi omicidi sia come autore sia come mandante. Entrava e usciva di galera, condannato più volte per “colpe nefandissime”, ma sempre protetto dal suo stato sociale e dalle sue floride casse.

La giovane figlia Beatrice, a quanto pare di una bellezza unica e rara (avuta dalla prima moglie Ersilia Santacroce), doveva sposarsi, ma il padre pur di non pagarle la dote, in quanto costretto a versare ingenti tributi per restare in libertà, decise di rinchiuderla insieme alla matrigna in un piccolo castello di famiglia, a Petrella Salto. Stando alle ricostruzioni, Beatrice e la matrigna Lucrezia vivevano in uno stato di reclusione, in una stanza dove il cibo veniva servito attraverso una fessura nella porta. In questa fortezza si consumavano continue violenze ai danni della giovane, una pressione psicologica talmente inimmaginabile che tutta la famiglia, dopo le richieste di aiuto della ragazza, decise che Francesco Cenci dovesse morire.
Il nucleo famigliare formato anche dai fratelli Giacomo e Bernardo, con l’aiuto del maniscalco e del castellano, organizzarono l’omicidio che doveva apparire un incidente.
Tutto andò storto, proprio come accade anche oggi nei goffi tentativi di sviare le indagini, il corpo fu abbandonato in un orto ai piedi della Rocca per simularne la caduta. In un primo momento non furono aperte indagini, ma quando iniziarono a circolare le voci che il Cenci fosse vittima di un omicidio, visti i suoi tanti nemici, fu disposta la riesumazione della salma.
Venne appurato che le ferite riportate erano “non compatibili con una caduta”, non vi era sangue sul luogo del ritrovamento e la lavandaia del castello confessò che Beatrice le fece lavare delle lenzuola intrise di sangue. Tutti i membri della famiglia furono arrestati e sottoposti a interrogatorio. Quando iniziarono a trapelare le prime notizie riguardanti la vicenda, vi furono subito delle agitazioni popolari.
Francesco Cenci per i romani era solo un bruto, Beatrice, invece, che si professò sempre innocente, se pur colpevole non si era macchiata ai loro occhi di alcun delitto in quanto si era liberata dal suo carnefice.
Nella Roma dell’inquisizione, prima della condanna si doveva ottenere la confessione degli accusati: “la regina delle prove”.
Il castellano e il maniscalco, sotto tortura, accusarono Beatrice di aver orchestrato tutto; lei, invece, fece ricadere le colpe sul solo castellano, Olimpio Calvetti.
Quando il maniscalco ritrattò le sue accuse, la situazione della ragazza parve iniziare a pendere in modo favorevole, ma sulla sua testa cadde nuovamente la testimonianza dei fratelli Giacomo e Bernardo, che, anch’essi torturati, puntarono il dito contro di lei. Qualcosa, dunque, nella ricostruzione non collimava, e l’opinione pubblica iniziò a farsi sempre più pressante. Il caso fu tolto al luogotenente Ulisse Moscato, secondo alcuni ammaliato dalla bellezza della ragazza, e affidato al tremendo giudice Cesare Luciani. Con il Luciani la storia divenne spietata: Beatrice fu torturata per giorni con le peggiori tecniche allora in circolazione.

Continuò a professarsi innocente anche quando il Luciani ordinò torture sempre più disumane, portandola a un passo dalla morte. Alla fine, stremata, la ragazza confessò. Si aprì così il processo, con le continue mobilitazioni del popolo che chiedevano invece la libertà e la grazia.
Oggi potremmo definire il processo di Beatrice come un eccellente caso mediatico. La sua difesa al cospetto del Papa venne affidata al più noto avvocato della città, tra i più illustri giuristi d’Italia, Prospero Farinacci.
Farinacci tentò di ribaltare la chiave di lettura del processo, con una bellissima arringa (riportata nel libro) sottolineò che Beatrice era, sì, reo confessa (sotto tortura), ma era soprattutto vittima del padre: il parricidio (tra i reati più gravi dell’epoca) doveva considerarsi giustificato, come un atto di ribellione contro il suo carnefice, e vendicare il suo onore violato dallo stupro – violenza, però, che non venne mai denunciata dalla ragazza.
“Non siamo qui venuti a difendere un parricidio, ma bensì per provare che alcuni sono del delitto innocenti, e che tutti sono scusabili e degni della commiserazione vostra”.
“Tutta la città sperava nella bontà del Pontefice”. Stando alla ricostruzione dell’anonimo, durante il processo, Clemente VII si era commosso ad ascoltare la storia, chiese una copia dei documenti presentati da Farinacci e una copia della sua arringa, per poter meditare con calma sulla decisione da prendere. L’accusa invece, come era scontato, chiedeva l’immediata condanna a morte dei colpevoli.
In attesa che la sentenza venisse pronunciata, proprio come nel libro di Lagioia, in città non si parlava d’altro, la storia aveva contaminato tutto, e tutti ne facevano una propria ricostruzione: ci si chiedeva come fosse possibile condannare una ragazza “già tanto infelice”; “pareva che ognuno si fosse preso l’incarico della difesa di Beatrice”.
Purtroppo, in quei giorni la città si macchiò di un nuovo parricidio e il responsabile fu sempre un esponente della famiglia Cenci. Quando Farinacci, sconvolto, apprese la notizia, capì che per Beatrice non vi era più scampo. Infatti, iniziarono delle pressioni per punire finalmente la famiglia Cenci, una famiglia nefasta per la città.

Il pontefice emise la condanna a morte di tutti i colpevoli e i romani non avevano ancora capito cose stesse accadendo. Un convoglio di soldati andò a prelevare Lucrezia e Beatrice dalla prigione Savella per condurle a Castel Sant’Angelo. I cittadini, vedendo le due donne scortate e non legate, si convinsero della loro grazia. Lungo via Giulia si creò una calca indescrivibile, dalle finestre si gettavano fiori, si gridava “Libertà!” e “Viva il papa!”, ma quando si intravide il patibolo allestito, dalla calca partirono calci e pugni, “otto giovanotti”, amici di Beatrice, cercarono di sottrarla alle guardie, vi fu una grande rissa ma il sopraggiungere di altri soldati impedì alla folla di salvare la ragazza. Le guardie attorno al patibolo furono raddoppiate, per il caldo, la calca e i continui tumulti, si verificarono innumerevoli morti tra la popolazione accorsa. Poi, in uno strano silenzio, Lucrezia e Beatrice furono decapitate, Giacomo venne squartato e Bernardo, non avendo partecipato attivamente all’omicidio, fu condannato all’ergastolo nelle carceri pontificie.
I corpi lasciati, esposti per alcune ore, vennero seppelliti in un cimitero senza lapide.
“Così si amministrava giustizia non solo in Roma ma in tutta l’Europa”.
Nessuno dimenticò Beatrice Cenci, nessuno mise mai in discussione la sua innocenza, perché per i romani il vero colpevole era il padre.
La città è da sempre teatro di innumerevoli omicidi, Roma come emblema delle stratificazioni storiche e sociali conserva tra le sue vie la memoria di tutto quello che accade. L’insieme dei ricordi crea e rilancia l’identità cittadina, fatta anche di drammi e ingiustizie.